 L’anno scorso, come molti dei nostri clienti ricorderanno, la Fiera era tutta puntata sul settore della saggistica, con la proposta di una intera e corposa biblioteca di un eclettico appassionato di ogni genere del sapere.
L’anno scorso, come molti dei nostri clienti ricorderanno, la Fiera era tutta puntata sul settore della saggistica, con la proposta di una intera e corposa biblioteca di un eclettico appassionato di ogni genere del sapere.
Quest’anno la lente è spostata invece sul libro di narrativa: “Libri da leggere”, come indica il titolo dato all’evento.
Eccoci, come ogni anno, all’appuntamento primaverile con la Fiera del Libro.
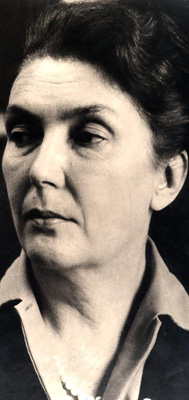
Grande spazio sarà riservato nei nostri scaffali all’offerta di un notevole numero di volumi (qualche migliaio di titoli) di “Narrativa del XXI secolo”, libri pubblicati negli ultimi 5-6 anni: nuovi quindi, un po’ al di fuori dello standard del libro usato di solito proposto nei nostri mercatini, ma ai soliti prezzi popolari che caratterizzano il nostro stile.
Il settore però che ci appare più interessante come proposta più specificamente culturale è una raccolta molto completa e consistente della produzione editoriale di narrativa italiana dagli anni ’50 agli anni ’80: oltre un migliaio di titoli di autori italiani pubblicati dalle storiche case editrici dell’epoca, da Mondadori ad Einaudi, Rizzoli, Bompiani, Longanesi.
Uno spaccato di una stagione quasi mitica dell’industria editoriale, in cui il libro aveva un peso specifico nel mondo intellettuale che oggi non ha più. Troviamo le prime prove di nomi famosi, scrittori passati ormai per giudizio unanime nella categoria dei classici, accanto alla produzione, a volte limitata ad un solo titolo, di autori cosiddetti minori, che però hanno contribuito con la loro opera a creare un clima culturale che fa parte della nostra storia. Spesso anzi sono proprio le opere “minori” a darci la percezione di un “tempo perduto” con il loro essere legate alle problematiche e alle atmosfere del momento storico a cui appartengono, con il loro non avere l’ampio respiro che fa dei grandi scrittori i portavoce di messaggi e contenuti che trascendono il particolare per parlare all’umanità di ogni epoca.
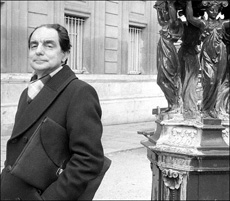
Abbiamo così la produzione letteraria degli anni ’50, legata ad un realismo urgente, che incanalava il bisogno di rielaborare le ferite recenti della guerra e del tragico conflitto civile degli anni ’43-’45.
Poi il desiderio di orizzonti più ampi, lo sperimentalismo, l’Italia del boom economico degli anni ’60 che ha voglia di guardare oltre.
L’impegno politico degli anni ’70, la letteratura di denuncia sociale, accanto al filone della narrativa borghese, che ritrae tutto un mondo della classe media in un ritorno ad un realismo meno crudo, più quotidiano.
La postazione di chi come noi recupera e cerca di rivalorizzare i libri che vengono “eliminati” o che riemergono da anni di oblio in cantine e solai, dà certamente un punto di vista un po’ particolare: ci si rende conto concretamente della volubilità della fortuna (chi legge più certi autori, come Virgilio Brocchi o Nino Salvaneschi, veri sfornatori di best-sellers degli anni ‘30/’40 a giudicare dai numeri di copie che ci passano tra le mani? o quale è il reale peso nella storia della narrativa italiana di autori come Carlo Cassola che pure invadeva le librerie negli anni ’60?).
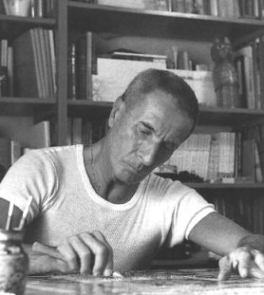
A volte, quando prezziamo la decimillesima copia del solito thriller o l’ennesimo titolo della infaticabile Danielle Steel (ma quanti libri ha scritto quella donna?), mentre ci rendiamo conto che in dieci anni di attività le copie de “Il tempo ritrovato” o di “Moby Dick” passate da noi si possono contare sulle dita delle mani, ci viene voglia di elaborare scientificamente un nuovo modo di classificare i libri, dal libro “leggi e getta” a quello che, quando arriva il fatidico momento di fare spazio in casa, non può perdere a nessun costo il suo posto in libreria.
La sensazione, anche nell’esperienza di osservatrice delle vetrine dei librai di questi nostri ultimi anni, è che la prima categoria stia prendendo sempre più il sopravvento. Ed anche per questo siamo molto orgogliosi di proporre nella nostra Fiera il sapore di un epoca in cui il libro aveva un posto diverso, meno marginale, nella vita dell’intera società, forse strumento principale della discussione culturale e della crescita intellettuale di intere generazioni.